Quando crollano le torri
Non scrivo quasi mai cercando di stare sul pezzo. Se c’è qualcosa di cui stanno parlando tutti, penso sempre che sia inopportuno e superfluo aggiungere al coro l’ennesima voce. Ma dopo il crollo della Torre dei Conti di Roma, e soprattutto dopo il profluvio di commenti esagitati sui social, vorrei provare a dire la mia.

Ovviamente non entro nel merito dell’episodio di cui non ho alcuna informazione tecnica e che ha visto pure la drammatica perdita di una vita umana, ma vorrei soffermarmi su un’evidenza molto più generale che forse non è abbastanza compresa: gli edifici sono strutture vive che respirano e si assestano. Le costruzioni nascono, invecchiano e muoiono. Passano la vita a resistere alla gravità, all’umidità, al sole, al freddo, al caldo, al vento, al fuoco, ai fulmini, ai sismi e all’azione umana. Ma non possono farlo per sempre.

Antonio Travi (1608-1665), Veduta costiera con pescatore e torre diruta
È certamente doveroso che la collettività cerchi di rallentare questo processo di usura per preservare ciò che costituisce un patrimonio di arte e di memoria. Ma è velleitario pensare di rendere eterne le opere dell’uomo, soprattutto le torri, che con il loro audace slancio verso il cielo sono quanto di più fragile si possa realizzare.

Thomas Cole, Scena costiera italiana con torre in rovina, 1838
A questo proposito trovo sempre molto attuale la teoria del teorico e pittore inglese John Ruskin (1819-1900) espressa ne Le sette lampade dell’architettura. Per lui le rovine sono simbolo del passare del tempo e della vittoria della natura sull’uomo, espressione, dunque, del ciclo di vita e morte di ogni cosa. La loro struggente bellezza non è artificiosa o fissa, ma in continuo mutamento. La rovina, inoltre, evoca un profondo senso del passato, di ciò che è stato perso e non tornerà più, offrendo una visione dolorosa ma esteticamente potente.

Johann Heinrich Füssli, La disperazione dell’artista di fronte alla grandezza delle rovine antiche, 1778-1780
Il restauro (che all’epoca prevedeva anche la totale ricostruzione di ciò che era andato perduto, l’eliminazione di tutti gli interventi successivi e l’invenzione di ciò che mai era stato edificato) è per lui una menzogna perché cancella i segni del tempo, che costituiscono la vera bellezza e l’anima dell’edificio. Intervenire su un’opera con il restauro, cercando di farla ritornare “nuova”, significa secondo Ruskin mancare di rispetto verso il suo ideatore e verso il suo processo di creazione. «È impossibile in architettura restaurare, come è impossibile resuscitare i morti», scrive a questo proposito.

Nicola Palizzi, Il terremoto di Melfi, 1851, olio su tela, Reggia di Caserta
Tuttavia, al di là del gusto romantico per il rudere, Ruskin promuoveva una visione molto pragmatica ed efficace: «prendetevi cura solerte dei vostri monumenti, e non avrete alcun bisogno di restaurarli». Per conservare un edificio bisogna praticare dunque una manutenzione ordinaria continua per evitare il degrado e la necessità di interventi ben più invasivi, accettando comunque il suo progressivo decadimento naturale.

Thomas Girtin, Castello di Denbigh, 1793
Questo insegnamento, quello di prevenire il restauro attraverso la manutenzione costante, non è mai entrato realmente nella pratica della gestione dei beni culturali. Il restauro arriva sempre tardi, quando il danno è già fatto, quando la rottura di qualche tegola ha portato a infiltrazioni d’acqua non più rimediabili, quando le strutture lignee sono ormai erose dagli insetti, quando le lesioni nella muratura si sono spalancate.

Jan Luyken, Galleria crollata durante una messa cattolica nella casa dell’ambasciatore spagnolo a Londra, 1623
Di torri crollate, purtroppo, la storia è piena. Di alcune abbiamo anche una preziosa testimonianza pittorica. È il caso della torre della Kreuzkirche di Dresda, che era allora la più antica chiesa della città, immortalata da Bernardo Bellotto nel 1751, durante il suo primo soggiorno in Sassonia.

Bernardo Bellotto, La Kreuzkirche a Dresda, 1751, olio su tela, cm 196×186, Gemäldegalerie, Dresda
La chiesa esibiva un poderoso westwerk quattrocentesco, una facciata occidentale turrita alta ben 96 metri. Nel 1760, nel corso della Guerra dei Sette Anni, la chiesa venne bombardata dall’artiglieria prussiana e il conseguente incendio fece crollare l’edificio. La facciata però rimase in piedi, sebbene danneggiata. Ma nel giugno del 1765, mentre la ricostruzione della retrostante chiesa era già avviata, la struttura rovinò al suolo sbriciolandosi in una montagna di macerie. È così che la vide di nuovo Bellotto, nel suo secondo soggiorno a Dresda.

Bernardo Bellotto, Le rovine della vecchia Kreuzkirche a Dresda, 1765, olio su tela, cm 84,5 x 107,3, Gemäldegalerie, Dresda
Nel nuovo dipinto la torre esibisce la sua sezione, come in un disegno architettonico. Non c’è nessun compiacimento estetico verso questa scena catastrofica. Quello di Bellotto è il tentativo di registrare la vita quotidiana di un popolo, anche nelle sue cadute e nei suoi momenti di fragilità. E tuttavia quella desolata rovina in mezzo alla piazza non può che fungere da monito: è metafora dello sfacelo dello stato sassone dopo un lungo conflitto nel corso del quale, per altro, anche la casa di Bellotto era stata completamente distrutta. La torre non venne più ricostruita.
Diverso è il caso di un’altra torre, ben più famosa: il campanile di San Marco a Venezia. Era il mattino del 14 luglio 1902 quando l’antica torre campanaria si sbriciolò con un boato in un’enorme nuvola di polvere. Il vecchio “paròn de casa“, come era chiamato affettuosamente dai veneziani, era collassato a causa delle profonde lesioni che si erano aperte sul lato nord-est, quello verso la basilica.

Sin dalla sua costruzione nella seconda metà del X secolo, il campanile aveva subito una serie infinita di danneggiamenti. Quelli più frequenti avvennero a partire dal XII secolo, quando fu dotato di una cuspide in legno rivestita di rame. Questa punta metallica attirava continuamente i fulmini che spesso generavano l’incendio della cella campanaria (ma in un caso questa prese fuoco per via dell’abitudine di accendervi torce per i festeggiamenti). Gli eventi più gravi si verificarono nel 1388 e nel 1489. Un quadro del 1505 attribuito a Giorgione mostra ancora il campanile mozzo, per via dei ritardi nella ricostruzione della cella campanaria e della copertura.

Giorgione, Madonna leggente, ca. 1505, olio su tavola, cm 76×60, Ashmolean Museum, Oxford
La nuova cella in marmo arriverà solo dopo il 1511, anno in cui un fortissimo terremoto produsse fessurazioni e cadute di calcinacci dai fianchi. Ma nei secoli seguenti altri fulmini continuarono a colpire il campanile rendendo necessari continui interventi. Un disegno di Canaletto del 1745 mostra un’impalcatura sospesa per riparare i danni del fulmine caduto proprio in quell’anno. Solo l’installazione di un parafulmine nel 1776 mise fine a questi eventi.

Canaletto, Venezia, il campanile in riparazione, ca. 1745, penna e inchiostro su carta, cm 42×29, Royal Collection Trust, Londra
All’inizio del Novecento il campanile si presentava in grave stato di degrado ma nessuno immaginava che sarebbe crollato. Dopo il disastro le autorità promisero immediatamente la ricostruzione del campanile e della Loggetta di Sansovino. Alcuni gruppi, ampiamente minoritari, proposero di non ricostruire affatto il campanile o di farlo in forme contemporanee, dunque nel linguaggio Art Nouveau. Ma alla fine prevalse la scelta di creare un “falso storico” ricostruendo il campanile “dov’era e com’era”.

La ricostruzione viene affidata a Luca Beltrami, già autore del restauro del castello Sforzesco di Milano, e a Gaetano Moretti. Il nuovo campanile sarà inaugurato il 25 aprile 1912, ma non è identico al precedente: è costruito con mattoni nuovi, ha una sagoma leggermente rastremata verso l’alto, ha la cella campanaria in cemento armato e contiene anche un ascensore.

Di questo restauro l’architetto Gustavo Giovannoni scriverà nel 1929: «Fiumi d’inchiostro si sono versati pro e contro la ricostruzione, e per lo stile nuovo o per l’imitazione dal vecchio. Ed in teoria tutti avevano ragione. Ma chi si trovava a Venezia negli anni in cui il campanile non esisteva più non poteva aver dubbi: Venezia, senza l’albero di maestra che dall’estremo della laguna o dall’aperto mare Adriatico annunziava la regina dei mari, non era più Venezia: piazza San Marco non aveva più la sua armonia e il suo significato… In questo contrastare tra i vari atteggiamenti della ragione, tra la ragione e il sentimento è la tragedia dei restauratori».
Della terza torre di cui vorrei raccontarvi, il campanile del Duomo di Pisa, ho scritto abbondantemente in un vecchio articolo. In quel caso la travagliata edificazione della torre ha richiesto durante tutta la sua esistenza continui interventi di manutenzione che, nonostante alcuni plateali errori che stavano rischiando di farla crollare, l’hanno portata a superare gli 850 anni pur con la sua evidente inclinazione.

René Magritte, Notte a Pisa, 1958
Insomma, qual è la morale di tutta questa storia? Molto semplicemente: dobbiamo considerare quasi un miracolo poter ammirare ancora costruzioni plurisecolari perché è nell’ordine delle cose che gli edifici, le torri, i ponti, un giorno possano crollare. Ma noi possiamo allontanare quel giorno prendendoci cura di quelle costruzioni con razionalità ed amorevole costanza.
***
Piccola postilla. Tutto quello che ho scritto fa parte della nostra concezione dell’opera d’arte e dell’architettura come pezzo unico e irripetibile. Tuttavia l’idea di prodotto originale e autentico è un concetto relativo e ha una base culturale.
Nella visione giapponese, per esempio, i templi vengono ricostruiti ogni 20 anni da zero – anche quelli millenari – proprio nell’accettazione della transitorietà di tutte le cose e nella convinzione che gli dei abbiano bisogno di una casa che si mantenga sempre nuova. La ricostruzione ha una forte valenza simbolica ed è un rituale che dura ben 8 anni. Alla fine la struttura, che non a caso è fatta in legno, rimane identica ma è realizzata con materiali nuovi. È allo stesso tempo rinnovata ed eterna.

Santuario di Ise, 690 d.C., Giappone – foto Tanuki
Questo sarebbe inaccettabile nella nostra concezione dell’architettura (per non parlare di Ruskin!), ma è bello sapere che esistono punti di vista così diversi dal nostro!
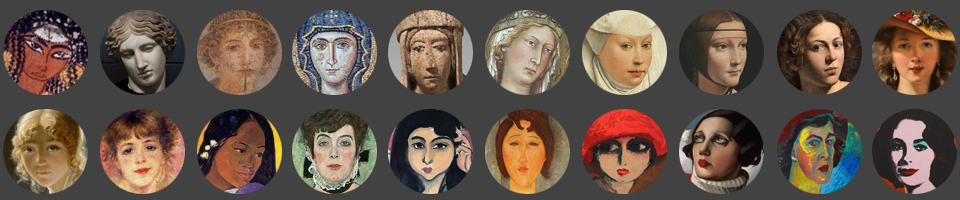





Ho scoperto casualmente che la Torre de’ Conti compare quasi certamente anche in una Madonna di Raffaello: la Esterhazy, databile al 1508. Sullo sfondo del dipinto si riconoscono alcuni noti edifici romani, tra cui le rovine del Foro di Nerva, il Tempio di Marte Ultore, il campanile della chiesa di San Basilio e, appunto, la Torre de’ Conti. (Zuffi S., La Madonna Esterhazy, 2014 e Shearman J., Raphael, Rome and the Codex Escurialensis – Master Drawings, 1977)
Grazie per questo approfondimento, Tiziano.
Pensavo di vedere citato anche il crollo della Torre Civica di Pavia, nel marzo 1989. Mai ricostruita.
Ho citato casi per i quali esistevano testimonianze pittoriche, non tutte le torri crollate in generale.
Oltre ai templi giapponesi, vorrei ricordare le moschee in adobe del sahel le cui mura vengono annualmente “rinfrescate” da nuovi strati di argilla dopo la stagione delle piogge, rendendole in pratica sempre “nuove”.
Interessante! Grazie per questo contributo, Gianni.
Gentile professoressa Pulvirenti,
Attuale e bellissimo articolo.Interessanti le varie analogie da lei trovate.
Anche a Parma, dove attualmente abito,il 27/1/1606 alle 15,30, crollò la torre più alta di Parma e di tutta Italia, di 130 metri.La torre civica si schianta verso la piazza, investendo il palazzo del capitano e la gente che vi stava camminando e sostando davanti.Non sarà più ricostruita.
In attesa di altre sue lezioni, come le chiamo io, invio cordiali saluti.
Grazie, ricambio i saluti.
Interessanti riflessioni ed approfondimenti, che condivido. Grazie!
È un piacere 🙂
“Tutto si bara tutto si cria” era un detto nel mio paese. Complimenti per l’ articolo, per la sua visione razionale degli eventi, anche se spiacevoli.
Grazie mille.
Bello ritrovarti, grazie per i tuoi interessantissimi articoli !
Grazie Anna, sono sempre qui, ma lavoro soprattutto alla sezione delle raccolte tematiche 🙂
Ogni giorno légion con tantissimo piacere i suoi scritti. Abito in Francia. Cercherò di condividerli con i miei contatti francesi.
Grazie e merci beaucoup !!!
Che bello! Grazie, Sylvianne.
E’ sempre un piacere sapere ogni volta qualcosa di nuovo, grazie!
Grazie mille, Monica.
Bellissimo articolo! Grazie
È un piacere
Splendido articolo e considerazioni sul restauro conservativo del patrimonio architettonico. Brava a condivido
🙂
Bellissimo articolo, grazie e complimenti!
Grazie a te, Edoardo!
La velocità di produrre una simile descrizione partendo da un fatto appena accaduto, dimostra, ancora una volta, la tua immensa preparazione. Complimenti e grazie percolmare le mia tante lacune
Ti ringrazio tanto, Anna!
Mi piace sempre leggere cioche scrive…tanto che ho in adozione il suo testo,Artelogia,nel mio liceo scientifico
Grazie per l’apprezzamento.
Non so come sia potuto accadere, ma che questo poveretto sia morto dopo una lunga agonia mi ha sconvolto. Possibile che non si siano accorti in tempo del pericolo? A volte penso che ostinarsi a mantenere in piedi strutture obsolete è molto simile all’accanimento terapeutico verso i malati . In ogni caso complimenti per i toni pacati ,il tempismo e la grande cultura
Ti ringrazio, Gabriella.
Ricchissimo e interessante post. Grazie.
Grazie, cara Anna Maria.